La schiavitù è la via verso il progresso o verso la distruzione. "Perché i peggiori arrivano al potere?"
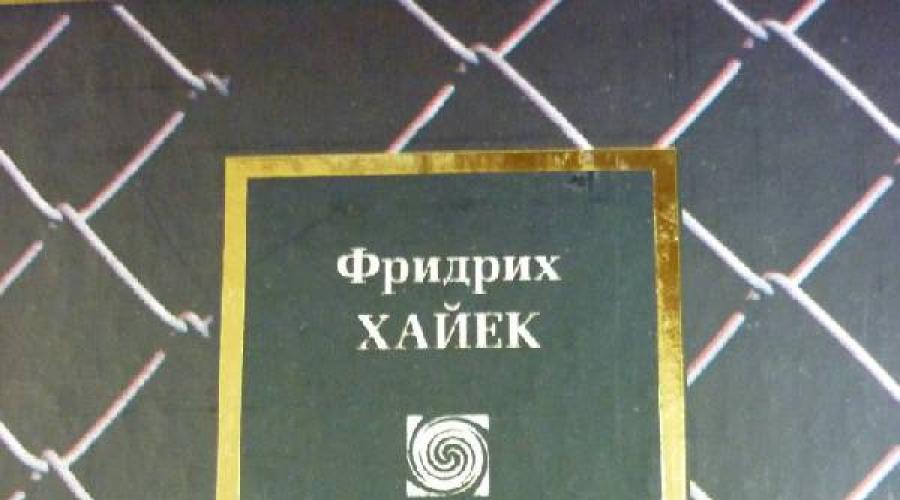
Friedrich August von Hayek
LA STRADA VERSO LA SCHIAVITÙ
Monografia
© Traduzione di M.B. Gnedovsky, 1990
[Prima pubblicazione: "Questioni di filosofia", 1990--1991]
Redattore Ts.S. Ginsburg
Jr. redattore A.Ya. Filimonova
Correttori di bozze di A. S. Rogozin
Hayek F.A. von, La strada verso la servitù: trad. dall'inglese / Prefazione N.Ya. Petrakova. - M.: "Economia", 1992. - 176 p.
Isbn 5--282--01501--3
BBK 65,9(4a)
Consegnato per il reclutamento il 28/03/91. Firmato per la pubblicazione il 06/04/91.
Tiratura 10.000 copie.
Casa editrice "Economy", 121864, Mosca, G-59, terrapieno Berezhkovskaya, 6
Socialisti di tutti i partiti
La libertà, qualunque essa sia, è perduta,
solitamente gradualmente.
Prefazione
Quando uno scienziato sociale scrive un libro politico, è suo dovere dirlo direttamente. Questo è un libro politico, e non voglio fingere che si tratti di qualcos'altro, anche se potrei designare il suo genere con un termine più raffinato, diciamo, un saggio socio-filosofico. Tuttavia, qualunque sia il titolo del libro, tutto ciò che vi scrivo deriva dal mio impegno verso alcuni valori fondamentali. E mi sembra di aver adempiuto ad un altro mio altrettanto importante dovere, avendo chiarito pienamente nel libro stesso quali sono i valori su cui si basano tutti i giudizi in esso espressi.
Resta da aggiungere che, nonostante si tratti di un libro politico, sono assolutamente sicuro che le convinzioni in esso espresse non siano espressione dei miei interessi personali. Non vedo perché una società del tipo che a quanto pare preferisco mi concederebbe qualche privilegio sulla maggioranza dei miei concittadini. In effetti, come sostengono i miei colleghi socialisti, io, come economista, occuperei un posto molto più importante nella società a cui mi oppongo (se, ovviamente, potessi accettare le loro opinioni). Sono altrettanto fiducioso che il mio disaccordo con queste opinioni non sia una conseguenza della mia educazione, poiché sono state proprio queste a cui ho aderito in giovane età e sono state loro che mi hanno costretto a dedicarmi agli studi professionali in economia. Per coloro che, come ormai è consuetudine, sono pronti a vedere motivazioni egoistiche in qualsiasi presentazione di una posizione politica, lasciatemi aggiungere che ho tutte le ragioni per non scrivere o pubblicare questo libro. Senza dubbio farà male a molti con i quali vorrei rimanere in amicizia. Per questo ho dovuto mettere da parte altri lavori che, nel complesso, considero più importanti e per i quali mi sento più preparato. Infine, danneggerà la percezione dei risultati delle mie attività di ricerca, verso le quali sento una genuina inclinazione.
Se nonostante ciò ho ritenuto mio dovere pubblicare questo libro, è stato solo a causa delle conseguenze strane e imprevedibili della situazione (appena percepibile dal grande pubblico) che si è sviluppata ora nelle discussioni sulla futura politica economica. Il fatto è che la maggior parte degli economisti sono stati recentemente coinvolti negli sviluppi militari e sono diventati muti a causa della posizione ufficiale che occupano. Di conseguenza, oggi l’opinione pubblica su questi temi è formata principalmente da dilettanti, da coloro che amano pescare in acque agitate o vendere a buon mercato un rimedio universale per tutte le malattie. In queste circostanze, chi ha ancora tempo per il lavoro letterario difficilmente ha il diritto di tenere per sé le paure che, osservando le tendenze moderne, molti condividono, ma non possono esprimere. In altre circostanze, lascerei volentieri il dibattito sulla politica nazionale a persone più autorevoli e più informate in materia.
Le principali disposizioni di questo libro furono brevemente riassunte per la prima volta nell'articolo "Libertà e sistema economico", pubblicato nell'aprile 1938 sulla rivista Contemporary Review, e ristampato nel 1939 in una versione ampliata in uno degli opuscoli socio-politici pubblicati sotto la modifica dal prof. G.D. Gideons University of Chicago Press. Ringrazio gli editori di entrambe queste pubblicazioni per avermi permesso di ristamparne alcuni estratti.
FA Hayek
La cosa più fastidiosa di questi studi è questa
che rivelano la genealogia delle idee.
Signore Acton
Gli eventi moderni differiscono da quelli storici in quanto non sappiamo dove conducono. Guardando indietro, possiamo comprendere gli eventi passati rintracciandone e valutandone le conseguenze. Ma per noi la storia attuale non è storia. È diretto verso l'ignoto e non possiamo quasi mai dire cosa ci aspetta. Tutto sarebbe diverso se avessimo la possibilità di rivivere gli stessi eventi una seconda volta, sapendo in anticipo quale sarebbe il loro risultato. Allora guarderemmo le cose con occhi completamente diversi e in ciò che ora notiamo a malapena vedremmo un presagio di cambiamenti futuri. Forse è meglio che tale esperienza sia chiusa all'uomo, che non conosca le leggi che governano la storia.
Eppure, sebbene la storia non si ripeta letteralmente e, d’altro canto, nessuno sviluppo degli eventi sia inevitabile, possiamo imparare dal passato per evitare il ripetersi di alcuni processi. Non è necessario essere un profeta per riconoscere il pericolo imminente. A volte una combinazione di esperienza e interesse consente improvvisamente a una persona di vedere le cose da un angolo che gli altri non vedono ancora.
Le pagine seguenti sono il frutto della mia esperienza personale. Il fatto è che sono riuscito a rivivere lo stesso periodo due volte, almeno due volte ad osservare un'evoluzione di idee molto simile. È improbabile che un'esperienza del genere sia disponibile per una persona che vive sempre in un paese, ma se vivi a lungo in paesi diversi, in determinate circostanze risulta realizzabile. Il fatto è che il pensiero della maggior parte delle nazioni civilizzate è soggetto sostanzialmente alle stesse influenze, ma queste si manifestano in tempi e velocità diverse. Pertanto, quando ci si sposta da un paese all'altro, a volte è possibile assistere due volte allo stesso stadio di sviluppo intellettuale. Allo stesso tempo, i sentimenti si aggravano stranamente. Quando si sentono per la seconda volta opinioni o appelli che si erano già sentiti venti o venticinque anni fa, essi acquistano un secondo significato, vengono percepiti come sintomi di una certa tendenza, come segni che indicano, se non l'inevitabilità, almeno la possibilità della stessa cosa della prima volta, sviluppi.
Forse è giunto il momento di dire la verità, per quanto amara possa sembrare: il paese di cui rischiamo di ripetere il destino è la Germania. È vero, il pericolo non è ancora alle porte e la situazione in Inghilterra e negli Stati Uniti è ancora piuttosto lontana da quella vista negli ultimi anni in Germania. Ma anche se la strada da fare è ancora lunga, dobbiamo essere consapevoli che ad ogni passo sarà sempre più difficile tornare indietro. E se, nel complesso, siamo padroni del nostro destino, allora in una situazione specifica agiamo come ostaggi delle idee che noi stessi abbiamo creato. Solo riconoscendo in tempo il pericolo possiamo sperare di affrontarlo.
L'Inghilterra moderna e gli Stati Uniti non sono come la Germania di Hitler come l'abbiamo conosciuta durante questa guerra. Ma chi comincia a studiare la storia del pensiero sociale difficilmente ignora la somiglianza, tutt’altro che superficiale, tra lo sviluppo delle idee avvenuto in Germania durante e dopo la prima guerra mondiale e le tendenze attuali che si sono diffuse nei paesi democratici. Qui oggi sta maturando la stessa determinazione a preservare le strutture organizzative create nel Paese per scopi di difesa per utilizzarle successivamente per la creazione pacifica. Qui si sviluppa lo stesso disprezzo per il liberalismo ottocentesco, lo stesso “realismo” ipocrita, la stessa disponibilità fatalistica ad accettare “tendenze inevitabili”. E almeno nove lezioni su dieci che i nostri rumorosi riformatori ci spingono a imparare da questa guerra sono esattamente le stesse lezioni che i tedeschi hanno imparato dall’ultima guerra e da cui è stato creato il sistema nazista. Più di una volta in questo libro avremo l'opportunità di assicurarci che sotto molti altri aspetti stiamo seguendo le orme della Germania, restando indietro di quindici-venticinque anni. Alla gente non piace ricordarlo, ma non è passato molto da quando i progressisti guardavano alle politiche socialiste della Germania come un esempio da seguire, proprio come negli ultimi tempi tutti gli occhi dei progressisti erano puntati sulla Svezia. E se scaviamo più a fondo nel passato, non possiamo fare a meno di ricordare quanto profondamente la politica e l’ideologia tedesca abbiano influenzato gli ideali di un’intera generazione di britannici e in parte americani alla vigilia della prima guerra mondiale.
L'autore ha trascorso più della metà della sua vita adulta nella sua terra natale, l'Austria, a stretto contatto con l'ambiente intellettuale tedesco, e la seconda metà negli Stati Uniti e in Inghilterra. Durante questo secondo periodo cresceva sempre più in lui la convinzione che le forze che distrussero la libertà in Germania fossero all'opera, almeno in parte, anche qui, e che la natura e le fonti del pericolo fossero qui meno comprese che ai tempi della Germania. Qui non hanno ancora visto in pieno la tragedia accaduta in Germania, dove persone di buona volontà, considerate un modello e suscitate ammirazione nei paesi democratici, hanno aperto la strada a forze che ormai incarnano tutto ciò che più odiamo. Le nostre possibilità di evitare un simile destino dipendono dalla nostra sobrietà, dalla nostra disponibilità a mettere in discussione le speranze e le aspirazioni che coltiviamo oggi e a rifiutarle se contengono pericolo. Nel frattempo tutto suggerisce che ci manca il coraggio intellettuale necessario per ammettere i nostri errori. Non vogliamo ancora vedere che l’ascesa del fascismo e del nazismo non sia stata una reazione alle tendenze socialiste del periodo precedente, ma un’inevitabile continuazione e sviluppo di queste tendenze. Molti non vogliono riconoscere questo fatto anche dopo che le somiglianze tra le peggiori manifestazioni dei regimi nella Russia comunista e nella Germania fascista sono diventate più chiare. Di conseguenza, molti, rifiutando il nazismo come ideologia e sinceramente non accettando nessuna delle sue manifestazioni, sono guidati nelle loro attività da ideali, la cui attuazione apre un percorso diretto alla tirannia che odiano.
Qualsiasi parallelo tra i percorsi di sviluppo dei diversi paesi è, ovviamente, ingannevole. Ma le mie argomentazioni non si basano solo su tali paralleli. Né insisto sull’inevitabilità di un percorso o di un altro. (Se le cose fossero così fatali, non avrebbe senso scrivere tutto questo.) Io sostengo che certe tendenze possono essere frenate se si fa capire in tempo alle persone dove sono realmente diretti i loro sforzi. Fino a poco tempo fa, però, c’erano poche speranze di essere ascoltati. Ora, secondo me, il momento è maturo per una discussione seria su tutto il problema nel suo insieme. E non è solo che sempre più persone oggi ne riconoscono la gravità; Ci sono anche ulteriori ragioni che ci costringono ad affrontare la verità.
Alcuni potrebbero dire che non è il momento di sollevare una questione che provoca uno scontro di opinioni così netto. Ma il socialismo di cui stiamo parlando qui non è una questione di partito, e ciò di cui stiamo discutendo non ha nulla a che fare con le discussioni che si svolgono tra partiti politici.* Che alcuni gruppi vogliono più socialismo e altri meno, che alcuni lo chiedono su basi sugli interessi di una parte della società, e di altri - di un'altra - tutto ciò non tocca l'essenza della questione. È successo che le persone che hanno l'opportunità di influenzare il corso dello sviluppo del paese sono tutte socialiste in un modo o nell'altro. Ecco perché è diventato fuori moda enfatizzare l’adesione alle convinzioni socialiste, perché questo fatto è diventato universale ed evidente. Quasi nessuno dubita che dobbiamo andare verso il socialismo, e tutte le controversie riguardano solo i dettagli di un tale movimento, la necessità di tener conto degli interessi di determinati gruppi.
Ci stiamo muovendo in questa direzione perché questa è la volontà della maggioranza, questo è il sentimento prevalente. Ma non c’erano e non ci sono fattori oggettivi che rendessero inevitabile il movimento verso il socialismo. (Tratteremo più avanti il mito dell’“inevitabilità” della pianificazione.) La domanda principale è dove ci porterà questo movimento. E se le persone la cui convinzione è il pilastro di questo movimento cominciassero a condividere i dubbi che la minoranza esprime oggi, non si ritrarranno con orrore dal sogno che agita gli animi da mezzo secolo, non lo abbandoneranno? Dove ci porteranno i sogni di tutta la nostra generazione è una questione che deve essere decisa non da un partito qualsiasi, ma da ciascuno di noi. Si può immaginare una grande tragedia se, mentre cerchiamo di risolvere consapevolmente la questione del futuro e ci concentriamo su ideali elevati, creiamo involontariamente in realtà l'esatto opposto di ciò a cui miriamo?
C’è un’altra ragione urgente che ci costringe oggi a pensare seriamente a quali forze abbiano dato vita al nazionalsocialismo. In questo modo possiamo capire meglio contro che tipo di nemico stiamo combattendo. Non c’è quasi bisogno di dimostrare che ancora non sappiamo bene quali siano gli ideali positivi che difendiamo in questa guerra. Sappiamo che difendiamo la libertà di modellare la nostra vita secondo le nostre idee. Questo è molto, ma non è tutto. Ciò non basta per mantenere ferme convinzioni di fronte a un nemico che usa la propaganda come una delle principali armi, non solo rozze, ma talvolta molto subdole. E ciò sarà tanto più insufficiente quando, dopo la vittoria, ci troveremo di fronte alla necessità di affrontare le conseguenze di questa propaganda, che senza dubbio si faranno sentire per molto tempo sia negli stessi paesi dell’Asse che in altri Stati che sono sotto la sua influenza. In questo modo non riusciremo né a convincere gli altri a combattere dalla nostra parte per solidarietà con i nostri ideali, né a costruire un nuovo mondo dopo la vittoria, ovviamente sicuro e libero.
Questo è un peccato, ma è un dato di fatto: l’intera esperienza di interazione dei paesi democratici con i regimi dittatoriali nel periodo prebellico, così come i loro successivi tentativi di condurre la propria propaganda e di formulare gli obiettivi della guerra, hanno rivelato un conflitto interno vaghezza, incertezza dei propri obiettivi, che può essere spiegata solo dalla mancanza di chiarezza degli ideali e dall'incomprensione della natura delle profonde differenze che esistono tra loro e il loro nemico. Ci siamo ingannati perché, da un lato, abbiamo creduto nella sincerità delle dichiarazioni del nemico e, dall’altro, ci siamo rifiutati di credere che il nemico professasse sinceramente alcune delle convinzioni che professiamo anche noi. Entrambi i partiti di sinistra e di destra non furono forse ingannati nel credere che i nazionalsocialisti fossero in difesa del capitalismo e contrari al socialismo in tutte le sue forme? Non ci è stato offerto come modello l'uno o l'altro elemento del sistema hitleriano, come se non fossero parte integrante di un tutto unico e potessero essere combinati in modo indolore e sicuro con le forme di vita di una società libera, custode della quale vorremmo sostenere? Abbiamo commesso molti errori molto pericolosi sia prima che dopo l'inizio della guerra semplicemente perché non abbiamo compreso adeguatamente il nostro nemico. Sembra che semplicemente non vogliamo capire come è nato il totalitarismo, perché questa comprensione minaccia di distruggere alcune illusioni care ai nostri cuori.
Non saremo in grado di interagire con successo con i tedeschi finché non capiremo da quali idee sono ora guidati e quale sia l’origine di queste idee. Le argomentazioni che negli ultimi tempi si sentono spesso sulla depravazione interna del popolo tedesco, non reggono alle critiche e non sembrano molto convincenti nemmeno a chi le avanza. Per non parlare del fatto che screditano tutta una galassia di pensatori inglesi che, nel corso dell'ultimo secolo, si sono costantemente rivolti al pensiero tedesco e ne hanno tratto il meglio (ma non solo il meglio). Ricordiamo, ad esempio, che quando ottant'anni fa John Stuart Mill scrisse il suo brillante saggio “Sulla libertà”, si ispirò principalmente alle idee di due tedeschi: Goethe e Wilhelm von Humboldt. [Per coloro che ne dubitano, posso raccomandare di ricorrere alla testimonianza di Lord Morley, che nelle sue “Memorie” definisce “generalmente accettato” che “le idee principali del saggio “0 Freedom” non sono originali, ma ci sono arrivate dalla Germania." ] D'altra parte, i due precursori più influenti delle idee del nazionalsocialismo furono uno scozzese e un inglese: Thomas Carlyle e Houston Stewart Chamberlain. In una parola, tali argomenti non fanno onore ai loro autori, perché, come è facile vedere, rappresentano una modificazione molto grossolana delle teorie razziali tedesche.
Il problema non è perché i tedeschi siano feroci (forse loro stessi non sono né migliori né peggiori di altre nazioni), ma quali sono le condizioni per cui, negli ultimi settant’anni, certe idee hanno acquisito forza e sono diventate dominanti nella società tedesca, e perché in seguito a ciò alcune persone salirono al potere in Germania. E se proviamo odio semplicemente per tutto ciò che è tedesco, e non per queste idee che oggi si sono impossessate delle menti dei tedeschi, difficilmente capiremo da che parte ci minaccia il vero pericolo. Un simile atteggiamento è molto spesso solo un tentativo di fuggire dalla realtà, di chiudere gli occhi di fronte a processi che non si svolgono affatto solo in Germania, un tentativo che si spiega con la riluttanza a riconsiderare le idee prese in prestito dai tedeschi e che non ci ingannano. meno degli stessi tedeschi. Ridurre il nazismo alla depravazione della nazione tedesca è doppiamente pericoloso, perché con questo pretesto è facile imporci proprio le istituzioni che sono la vera causa di questa depravazione.
L'interpretazione degli eventi in Germania e in Italia offerta in questo libro differisce notevolmente dalle opinioni su questi eventi espresse dalla maggior parte degli osservatori stranieri e degli emigranti politici di questi paesi. E se il mio punto di vista è corretto, allora spiegherà allo stesso tempo perché gli emigranti e i corrispondenti dei giornali inglesi e americani, la maggior parte dei quali professano idee socialiste, non riescono a vedere questi eventi nella loro vera forma. La teoria superficiale e in definitiva errata, che riduce il nazionalsocialismo a una mera reazione deliberatamente provocata da gruppi i cui privilegi e interessi erano minacciati dall’avanzata del socialismo, trova sostegno tra tutti coloro che un tempo parteciparono attivamente al movimento ideologico che si concluse con la vittoria. del nazionalsocialismo, ma ad un certo punto entrò in conflitto con i nazisti e fu costretto a lasciare il suo Paese. Ma il fatto che queste persone costituissero l’unica significativa opposizione al nazismo significa solo che, in senso lato, quasi tutti i tedeschi divennero socialisti e che il liberalismo nella sua accezione originaria cedette completamente il posto al socialismo. Cercherò di dimostrare che il conflitto tra le forze di “sinistra” e i nazionalsocialisti di “destra” in Germania è un conflitto inevitabile che sorge sempre tra fazioni socialiste rivali. E se il mio punto di vista è corretto, ne consegue che gli emigranti socialisti che continuano a restare fedeli alle loro convinzioni contribuiscono di fatto, anche se con le migliori intenzioni, a riportare il paese che li ha accolti sulla strada percorsa dalla Germania.
So che molti dei miei amici inglesi sono scioccati dalle opinioni semifasciste spesso espresse dai rifugiati tedeschi, che per le loro convinzioni sono indubbiamente socialisti. Gli inglesi tendono a spiegarlo con l'origine tedesca degli emigranti, ma in realtà la ragione risiede nelle loro opinioni socialiste. Essi semplicemente ebbero la possibilità di fare molti passi più avanti nello sviluppo delle loro idee rispetto ai socialisti inglesi o americani. Naturalmente, i socialisti tedeschi ricevettero un sostegno significativo in patria a causa delle peculiarità della tradizione prussiana. L'affinità interna del prussianesimo e del socialismo, che in Germania era motivo di orgoglio nazionale, non fa altro che sottolineare la mia idea principale. [Una certa affinità tra il socialismo e l'organizzazione dello Stato prussiano è innegabile. Era già stato riconosciuto dai primi socialisti francesi. Molto prima che l’ideale di governare un intero paese sul modello della fabbrica cominciasse a ispirare i socialisti del diciannovesimo secolo, il poeta prussiano Novalis lamentava che “nessun paese è mai stato governato così sul modello di una fabbrica come la Prussia dopo la morte di Federico Guglielmo” (vedi Novalis
Strada verso la schiavitù
Socialisti di tutti i partiti
Prefazione
La libertà, qualunque essa sia, di solito viene persa gradualmente.
Quando uno scienziato sociale scrive un libro politico, è suo dovere dirlo direttamente. Questo è un libro politico e non voglio fingere che parli di qualcos'altro, anche se potrei designare il suo genere con un termine più raffinato, ad esempio un saggio socio-filosofico. Tuttavia, qualunque sia il titolo del libro, tutto ciò che vi scrivo deriva dal mio impegno verso alcuni valori fondamentali. E mi sembra di aver adempiuto ad un altro mio altrettanto importante dovere, avendo chiarito pienamente nel libro stesso quali sono i valori su cui si basano tutti i giudizi in esso espressi.
Resta da aggiungere che, nonostante si tratti di un libro politico, sono assolutamente sicuro che le convinzioni in esso espresse non siano espressione dei miei interessi personali. Non vedo perché una società del tipo che ovviamente preferisco mi concederebbe dei privilegi rispetto alla maggioranza dei miei concittadini. In effetti, come sostengono i miei colleghi socialisti, io, come economista, occuperei un posto molto più importante nella società a cui mi oppongo (se, ovviamente, potessi accettare le loro opinioni). Sono altrettanto fiducioso che il mio disaccordo con queste opinioni non sia una conseguenza della mia educazione, poiché sono state proprio queste a cui ho aderito in giovane età e sono state loro che mi hanno costretto a dedicarmi agli studi professionali in economia. Per coloro che, come ormai è consuetudine, sono pronti a vedere motivazioni egoistiche in qualsiasi presentazione di una posizione politica, lasciatemi aggiungere che ho tutte le ragioni per non scrivere o pubblicare questo libro. Senza dubbio offenderà molti con i quali vorrei rimanere in rapporti amichevoli. A causa sua ho dovuto rimandare altri lavori, che generalmente considero più importanti e per i quali mi sento più preparato. Infine, danneggerà la percezione dei risultati della mia attività di ricerca, in senso proprio, verso la quale sento una reale inclinazione.
Se nonostante ciò ho ritenuto mio dovere pubblicare questo libro, è stato solo a causa delle conseguenze strane e imprevedibili della situazione (appena percepibile dal grande pubblico) che si è sviluppata ora nelle discussioni sulla futura politica economica. Il fatto è che la maggior parte degli economisti sono stati recentemente coinvolti negli sviluppi militari e sono diventati muti a causa della posizione ufficiale che occupano. Di conseguenza, oggi l’opinione pubblica su questi temi è formata principalmente da dilettanti, da coloro che amano pescare in acque agitate o vendere a buon mercato un rimedio universale per tutte le malattie. In queste circostanze, chi ha ancora tempo per il lavoro letterario difficilmente ha il diritto di tenere per sé le paure che, osservando le tendenze moderne, molti condividono, ma non possono esprimere. In altre circostanze, lascerei volentieri il dibattito sulla politica nazionale a persone più autorevoli e più informate in materia.
Le principali disposizioni di questo libro furono riassunte per la prima volta nell’articolo “Libertà e sistema economico”, pubblicato nell’aprile 1938 sulla rivista Contemporary Review, e ristampato nel 1939 in una versione ampliata in uno dei “Socio-Political Pamphlets”, che pubblicato sotto la direzione del prof. GD Gideons University of Chicago Press. Ringrazio gli editori di entrambe queste pubblicazioni per avermi permesso di ristamparne alcuni estratti.
FA Hayek
introduzione
Volta è particolarmente irritato da quegli studi che rivelano il pedigree delle idee.
Signore Ekton
Gli eventi moderni differiscono da quelli storici in quanto non sappiamo dove conducono. Guardando indietro, possiamo comprendere gli eventi passati rintracciandone e valutandone le conseguenze. Ma per noi la storia attuale non è storia. È diretto verso l'ignoto e non possiamo quasi mai dire cosa ci aspetta. Tutto sarebbe diverso se avessimo la possibilità di rivivere gli stessi eventi una seconda volta, sapendo in anticipo quale sarebbe il loro risultato. Allora guarderemmo le cose con occhi completamente diversi e in ciò che ora notiamo a malapena vedremmo un presagio di cambiamenti futuri. Forse è meglio che tale esperienza sia chiusa all'uomo, che non conosca le leggi che governano la storia.
Eppure, sebbene la storia non si ripeta letteralmente e, d’altro canto, nessuno sviluppo degli eventi sia inevitabile, possiamo imparare dal passato per evitare la ripetizione di alcuni processi. Non è necessario essere un profeta per riconoscere il pericolo imminente. A volte una combinazione di esperienza e interesse consente improvvisamente a una persona di vedere le cose da un angolo che gli altri non vedono ancora.
Le pagine seguenti sono il frutto della mia esperienza personale. Il fatto è che sono riuscito a rivivere lo stesso periodo due volte, almeno due volte ad osservare un'evoluzione di idee molto simile. È improbabile che un'esperienza del genere sia disponibile per una persona che vive sempre in un paese, ma se vivi a lungo in paesi diversi, in determinate circostanze risulta realizzabile. Il fatto è che il pensiero della maggior parte delle nazioni civilizzate è soggetto sostanzialmente alle stesse influenze, ma queste si manifestano in tempi e velocità diverse. Pertanto, quando ci si sposta da un paese all'altro, a volte è possibile assistere due volte allo stesso stadio di sviluppo intellettuale. Allo stesso tempo, i sentimenti si aggravano stranamente. Quando si sentono per la seconda volta opinioni o appelli che si erano già sentiti venti o venticinque anni fa, acquistano un secondo significato, vengono percepiti come sintomi di una certa tendenza, come segni che indicano, se non l'inevitabilità, almeno , la possibilità dello stesso. come la prima volta, lo sviluppo degli eventi.
Forse è giunto il momento di dire la verità, per quanto amara possa sembrare; Il paese di cui rischiamo di ripetere la sorte è la Germania. È vero che il pericolo non è ancora alle porte e la situazione in Inghilterra e negli Stati Uniti è ancora molto lontana da quella osservata negli ultimi anni in Germania. Ma, anche se la strada da fare è ancora lunga, dobbiamo essere consapevoli che ad ogni passo sarà sempre più difficile tornare indietro. E se, nel complesso, siamo padroni del nostro destino, allora in una situazione specifica agiamo come ostaggi delle idee che noi stessi abbiamo creato. Solo riconoscendo in tempo il pericolo possiamo sperare di affrontarlo.
L'Inghilterra moderna e gli Stati Uniti non sono come la Germania di Hitler come l'abbiamo conosciuta durante questa guerra. Ma chi comincia a studiare la storia del pensiero sociale difficilmente ignora la somiglianza, tutt’altro che superficiale, tra lo sviluppo delle idee avvenuto in Germania durante e dopo la prima guerra mondiale e le tendenze attuali che si sono diffuse nei paesi democratici. Qui oggi sta maturando la stessa determinazione a preservare le strutture organizzative create nel Paese per scopi di difesa per utilizzarle successivamente per la creazione pacifica. Qui si sviluppa lo stesso disprezzo per il liberalismo ottocentesco, lo stesso “realismo” ipocrita, la stessa fatalistica disponibilità ad accettare “tendenze inevitabili”. E almeno nove lezioni su dieci che i nostri rumorosi riformatori ci spingono a imparare da questa guerra sono esattamente le stesse lezioni che i tedeschi hanno imparato dall’ultima guerra e da cui è stato creato il sistema nazista. Più di una volta in questo libro avremo l'opportunità di assicurarci che sotto molti altri aspetti stiamo seguendo le orme della Germania, restando indietro di quindici-venticinque anni. Alla gente non piace ricordarlo, ma non sono passati molti anni da quando i progressisti guardavano alle politiche socialiste della Germania come un esempio da seguire, proprio come negli ultimi tempi tutti gli occhi dei progressisti erano puntati sulla Svezia. E se scaviamo più a fondo nel passato, non possiamo fare a meno di ricordare quanto profondamente la politica e l’ideologia tedesca abbiano influenzato gli ideali di un’intera generazione di britannici e in parte americani alla vigilia della prima guerra mondiale.
L'autore ha trascorso più della metà della sua vita adulta nella sua terra natale, l'Austria, a stretto contatto con l'ambiente intellettuale tedesco, e la seconda metà negli Stati Uniti e in Inghilterra. Durante questo secondo periodo crebbe gradualmente in lui la convinzione che le forze che distrussero la libertà in Germania fossero all'opera, almeno in parte, anche qui, e che la natura e le fonti del pericolo fossero qui meno comprese che ai tempi della Germania. Qui non hanno ancora visto in pieno la tragedia accaduta in Germania, dove persone di buona volontà, considerate un modello e suscitate ammirazione nei paesi democratici, hanno aperto la strada a forze che ormai incarnano tutto ciò che più odiamo. Le nostre possibilità di evitare un simile destino dipendono dalla nostra sobrietà, dalla nostra disponibilità a mettere in discussione le speranze e le aspirazioni che coltiviamo oggi e a rifiutarle se contengono pericolo. Nel frattempo tutto suggerisce che ci manca il coraggio intellettuale necessario per ammettere i nostri errori. Non vogliamo ancora vedere che l’ascesa del fascismo e del nazismo non sia stata una reazione alle tendenze socialiste del periodo precedente, ma un’inevitabile continuazione e sviluppo di queste tendenze. Molti non vogliono riconoscere questo fatto anche dopo che le somiglianze tra le peggiori manifestazioni dei regimi nella Russia comunista e nella Germania fascista sono diventate più chiare. Di conseguenza, molti, rifiutando il nazismo come ideologia e sinceramente non accettando nessuna delle sue manifestazioni, sono guidati nelle loro attività da ideali, la cui attuazione apre un percorso diretto alla tirannia che odiano.
Strada verso la schiavitù
©Friedrich August von Hayek, 1944
© Traduzione. M. Gnedovsky, 2010
© Edizione russa AST Publishers, 2010
Prefazione alla ristampa del 1976
Con questo libro, scritto nel mio tempo libero nel 1940-1943, quando lavoravo principalmente su problemi di teoria economica pura, inaspettatamente per me iniziarono i miei oltre trent'anni di lavoro in un nuovo campo. Il primo tentativo di trovare una nuova direzione fu motivato dalla mia irritazione per l'interpretazione completamente errata del movimento nazista negli ambienti "progressisti" britannici. Questa irritazione mi portò a scrivere una nota all'allora direttore della London School of Economics, Sir William Beveridge, e poi un articolo per la Contemporary Review del 1938, che io, su richiesta del professor Harry D. Gideons, ampliai per la pubblicazione. nei suoi Public Policy Pamphlets e che, con grande riluttanza (scoprendo che tutti i miei colleghi britannici più competenti sono occupati con l'andamento delle ostilità) ho finalmente trasformato in questo trattato. Nonostante il successo del tutto inaspettato di The Road to Serfdom (e l'edizione americana inizialmente prevista ebbe ancora più successo di quella britannica), per molto tempo non ne fui soddisfatto. Sebbene il libro affermi onestamente fin dall'inizio che è di natura politica, i miei colleghi di scienze sociali sono riusciti a instillare in me la sensazione che stavo facendo la cosa sbagliata, e io stesso ero confuso sul fatto di essere abbastanza competente per andare oltre. i confini dell’economia nel senso tecnico del termine. Non parlerò qui del furore che il mio libro ha suscitato in certi ambienti, né della curiosa differenza tra la sua accoglienza in Gran Bretagna e negli Stati Uniti - ne ho scritto un paio di decenni fa nella "Prefazione al First American Pocket Edizione " Giusto per dare un'idea della reazione comune, citerò un episodio in cui un noto filosofo, il cui nome resterà anonimo, scrisse ad un altro filosofo una lettera in cui lo rimproverava di elogiare questo libro scandaloso, che egli stesso "ovviamente non aveva letto." Sebbene mi sforzassi di rimanere nell’ambito dell’economia vera e propria, non potevo fare a meno di pensare che le questioni che avevo sollevato con tanta noncuranza fossero più complesse e importanti di quelle della teoria economica, e che ciò che era detto nella versione originale del mio lavoro necessitava di chiarimenti e perfezionamenti. Quando ho scritto questo libro, non ero affatto sufficientemente libero dai pregiudizi e dai pregiudizi che governano l'opinione pubblica, e ancor meno in grado di evitare la solita confusione di termini e concetti, cosa alla quale in seguito ho iniziato a prestare molta attenzione. La discussione che ho intrapreso sulle conseguenze della politica sociale non può, ovviamente, essere completa senza un’adeguata considerazione dei requisiti e delle possibilità di un ordine di mercato adeguatamente organizzato. È a quest’ultimo problema che sono dedicati i miei ulteriori studi in quest’area. Il primo risultato dei miei sforzi per spiegare l’ordine della libertà fu un importante studio, La Costituzione della Libertà (1960), in cui tentai di riformulare sostanzialmente ed esprimere in modo più coerente le dottrine classiche del liberalismo del diciannovesimo secolo. La consapevolezza che una tale riformulazione lasciava una serie di importanti domande senza risposta mi ha spinto a fornire le mie risposte ad esse nell’opera in tre volumi Diritto, Legislazione e Libertà, il primo volume della quale è stato pubblicato nel 1973.
Mi sembra di essere riuscito a imparare molto negli ultimi vent'anni sui problemi sollevati in questo libro, anche se in questo periodo non credo nemmeno di averlo riletto. Rileggendolo adesso per scrivere questa prefazione, ho sentito per la prima volta che non solo non me ne vergognavo, ma, al contrario, ne ero orgoglioso – anche per le scoperte che mi hanno permesso di dedicarlo ai “socialisti di tutti i partiti”. Infatti, anche se durante questo periodo ho letto molte cose che non sapevo quando l'ho scritto, ora sono spesso sorpreso di quanto di ciò che ho capito allora, proprio all'inizio del mio viaggio, sia stato confermato da ulteriori ricerche. . E anche se i miei lavori successivi si riveleranno, spero, più utili ai professionisti, sono pronto senza esitazione a raccomandare questo vecchio libro al lettore generale che desidera un'introduzione semplice, non sovraccarica di dettagli tecnici, a un problema che, a mio avviso, , rimane uno dei più urgenti ed è ancora in attesa di una decisione.
Il lettore probabilmente si chiederà se ciò significa che sono ancora pronto a difendere tutte le principali conclusioni di questo libro, e la risposta sarà generalmente positiva. L’avvertimento più significativo da fare è che la terminologia è cambiata nel tempo, e quindi gran parte di ciò che viene detto qui potrebbe essere frainteso. All’epoca in cui scrissi La strada verso la servitù, il socialismo era chiaramente inteso come la nazionalizzazione dei mezzi di produzione e la pianificazione economica centralizzata che la nazionalizzazione rende possibile e necessaria. In questo senso, la Svezia odierna, ad esempio, è organizzata in modo molto meno socialista rispetto alla Gran Bretagna o all'Austria, sebbene sia generalmente accettato che la Svezia sia un paese molto più socialista. Ciò accadde perché il socialismo cominciò ad essere inteso principalmente come un’ampia redistribuzione del reddito attraverso la tassazione e le istituzioni dello “stato sociale”. Sotto questo tipo di socialismo, i fenomeni discussi in questo libro si verificano più lentamente, non sono così diretti e non sono pienamente espressi. Credo che alla fine questo porterà agli stessi risultati, anche se i processi stessi non saranno esattamente gli stessi descritti nel mio libro.
Mi viene spesso attribuita la conclusione che qualsiasi movimento verso il socialismo porta necessariamente al totalitarismo. Sebbene questo pericolo esista, non è questo lo scopo del libro. Il punto principale è che se non riconsideriamo i principi della nostra politica, ci troveremo ad affrontare le conseguenze più spiacevoli, che non erano affatto l’obiettivo della maggior parte dei sostenitori di questa politica.
Dove, come mi sembra oggi, ho sbagliato è stato sottovalutare l’esperienza del comunismo in Russia. Forse questa mancanza può essere perdonata, dato che negli anni in cui scrivo, la Russia era nostra alleata in guerra, e io non mi ero ancora del tutto liberato dai pregiudizi interventisti usuali per quel tempo, e quindi mi sono permesso di fare molte concessioni - a mio parere oggi, ingiustificato. E di certo non mi rendevo pienamente conto di quanto le cose fossero brutte sotto tanti aspetti. Ad esempio, ho considerato la domanda che ho posto a pag. 98: se “Hitler ricevesse un potere illimitato con mezzi strettamente costituzionali<…>Qualcuno oserà affermare su questa base che in Germania esiste ancora lo Stato di diritto?” Tuttavia, in seguito si scoprì che questo è esattamente ciò che sostenevano i professori Hans Kelsen e Harold J. Laski e, sulla scia di questi influenti autori, altri giuristi e politologi socialisti. Comunque sia, l’ulteriore esplorazione dei movimenti intellettuali moderni e delle istituzioni moderne non ha fatto altro che aumentare le mie paure e le mie ansie. E l'influenza delle idee socialiste, unita a un'ingenua fede nelle buone intenzioni di coloro nelle cui mani è concentrato il potere totalitario, è aumentata in modo significativo da quando ho scritto The Road to Serfdom.
Per molto tempo mi ha infastidito il fatto che il lavoro, che consideravo un opuscolo sull'argomento del giorno, fosse più conosciuto dei miei veri e propri lavori scientifici. Tuttavia, guardando ciò che ho scritto attraverso il prisma di ulteriori studi su questioni sollevate più di trent’anni fa, non provo più fastidio. Anche se in questo libro ci sono molte cose che non sono riuscito a dimostrare in modo convincente, è stato un tentativo sincero di trovare la verità e penso di aver fatto alcune scoperte che andranno a beneficio anche di coloro che non sono d'accordo con me e li aiuteranno a evitare seri pericoli. .
La strada verso la schiavitù di Friedrich von Hayek è il libro più famoso del premio Nobel per l'economia nel 1974. L'opera è stata tradotta in più di 20 lingue ed è considerata una delle opere fondamentali del liberalismo classico. Il libro ha avuto un enorme impatto sulla politica e sull’economia mondiale moderna, è diventato la base per le idee per l’abbandono della regolamentazione statale e ha motivato il ritorno al modello classico di un mercato competitivo nel Regno Unito sotto e negli Stati Uniti sotto Ronald Reagan.
idea principale
L'idea chiave del libro "The Road to Serfdom" di Friedrich von Hayek è che la regolamentazione pianificata dell'economia porta irreversibilmente alla crescita dell'ideologia socialista. E questo, a sua volta, è il primo passo significativo verso il totalitarismo.
Secondo lo stesso Hayek, il nazismo e il fascismo raggiunsero il loro apice, diventando non una reazione alle tendenze socialiste, ma il loro inevitabile sviluppo.
Il filosofo ed economista austriaco era convinto che il rifiuto delle libertà economiche a favore della pianificazione centrale e del collettivismo portasse alla privazione dei cittadini non solo delle libertà economiche, ma anche delle libertà umane fondamentali. Questa è quella che lui chiamava “la strada verso la schiavitù”.
Il linguaggio di questo libro, nonostante il suo contenuto profondo e complesso, è il più semplice possibile, il che ha permesso di tradurlo in diverse dozzine di lingue e gli abitanti dell'intero pianeta hanno potuto conoscere le idee in esso presentate.

Il libro inizia con il capitolo “Il sentiero rifiutato”, in cui Hayek fornisce la sua interpretazione dei recenti eventi storici. La strada verso la servitù fu pubblicata nel 1944, mentre la guerra mondiale volgeva al termine. L'economista osserva che questa guerra non fu solo un conflitto militare in cui furono coinvolti quasi tutti i paesi europei, ma anche una lotta ideologica avvenuta nel quadro della civiltà europea.
In The Road to Serfdom, Friedrich von Hayek sostiene che è la negazione delle libertà economiche che porta alla formazione del totalitarismo. Entro la fine del 19 ° secolo, la fiducia in tutto il mondo stava diminuendo, causata dal desiderio di rapidi cambiamenti, dal desiderio di distruggere il vecchio mondo per costruirne uno nuovo.
Nel capitolo “La Grande Utopia”, l’autore descrive come, sotto la bandiera della libertà, il liberalismo venga sostituito nel mondo dal socialismo. Il socialismo, che Hayek inizialmente considerava un movimento totalitario, fu l’ultimo tentativo dei leader della Rivoluzione francese di portarlo fino in fondo riorganizzando e stabilendo deliberatamente il “potere spirituale”.
Il libro "The Road to Serfdom" di Friedrich von Hayek è diviso in 15 capitoli, ognuno dei quali contiene un'affermazione fondamentale. Nel capitolo "Individualismo e collettivismo", l'autore osserva che il problema principale dei socialisti è la loro fede in due cose incompatibili: organizzazione e libertà. Il termine stesso implica protezione sociale della popolazione, uguaglianza e giustizia universale. Ma per raggiungere questo ideale vengono applicati i principi di un’economia pianificata.
Il liberalismo presuppone la massima prevenzione dei monopoli, la creazione di un quadro legislativo potente, la lotta contro la corruzione e la frode, l’ignoranza e gli abusi.
Secondo Hayek, l'odio per la concorrenza in ogni sua manifestazione diventa comune a tutti i socialisti.
Pianificazione inevitabile
“La pianificazione è inevitabile?” – questa è la domanda che l'autore pone nel titolo del quarto capitolo. Hayek, in The Road to Serfdom, cerca dettagliatamente di smontare l’affermazione secondo cui, a causa dello sviluppo della tecnologia, il mercato è stato infine monopolizzato.
Uno degli argomenti chiave a sostegno della necessità della pianificazione è che a causa dei monopoli ci sono solo due opzioni: trasferire il controllo della produzione al governo o iniziare a controllare i monopoli privati.
Secondo Hayek, i monopoli nascono molto spesso grazie ad accordi segreti e al sostegno diretto di grandi funzionari governativi, piuttosto che come conseguenza di qualsiasi sviluppo economico. Eliminando questo ostacolo si possono creare le condizioni ideali per stimolare la concorrenza.
Nel suo libro “La via della servitù” Friedrich August von Hayek scrive che l’unica via d’uscita da questa situazione è il decentramento. Il controllo diretto deve essere abolito a favore del coordinamento. Al massimo può trattarsi di un sistema di misure necessario per coordinare le azioni di altri partecipanti al mercato.
Nel capitolo “Pianificazione e democrazia”, Hayek nota che il comunismo, i sistemi collettivisti e il fascismo differiscono solo nei loro obiettivi finali. Ciò che hanno in comune è l'organizzazione consapevole delle forze produttive destinate a svolgere un compito specifico. Quando inizi a costruire il tuo lavoro secondo un piano specifico, è importante distinguere tra i bisogni di ciascun individuo, inserendoli in un unico sistema di valori, che è subordinato all'idea statale.
In The Road to Serfdom, Friedrich Hayek sottolinea che la libertà non viene distrutta dalla dittatura stessa, ma dalla pianificazione, che porta inevitabilmente alla dittatura, poiché diventa uno strumento necessario in una società di pianificazione su larga scala.
"Piano e Legge"

Il capitolo “Piano e Legge” è dedicato alle differenze che esistono tra le cosiddette “regole di merito” adottate dagli enti urbanistici e il diritto formale. La differenza tra loro è esattamente la stessa delle regole della strada e degli ordini su quale direzione muoversi successivamente.
Nella prima versione non si riferiscono a persone e obiettivi specifici, ma nella seconda si rivolgono a individui specifici, spingendoli a lavorare per un determinato obiettivo.
In The Road to Serfdom, von Hayek sottolinea che per controllare intere nazioni è necessario un gruppo di esperti o una figura di qualche tipo di comandante in capo, nelle cui mani è tutto il potere non legato alle procedure democratiche. Egli giunge a questa conclusione nel capitolo “Controllo economico e totalitarismo”.
Definisce la perdita della libertà di scelta come situazioni in cui i cittadini, invece di specifiche ricompense monetarie, iniziano a ricevere posizioni pubbliche, distinzioni e privilegi. La vita economica si trova sotto il controllo totale, una persona perde l'opportunità di fare anche solo un passo senza dichiarare pubblicamente i propri obiettivi e intenzioni. Tutta la vita umana è sotto controllo. La stessa immagine di "The Road to Serfdom" di F. Hayek sarà descritta da Orwell qualche anno dopo nel romanzo "1984".
"Chi vincerà?"

L'essenza del capitolo "Chi vince?" è che, avendo perso la proprietà privata, la società è privata della libertà. Allo stesso tempo, le risorse reali finiscono nelle mani dello Stato o di alcune strutture influenti.
La pianificazione statale della produzione porta alla fine al controllo totale sulle risorse prodotte, osserva l'autore, e questo limita notevolmente le relazioni di mercato. Quando raggiungono un punto critico, diventa necessario diffonderli fino a renderli esaustivi.
Tutto ciò porta al fatto che l'individuo perde il lavoro, diventando dipendente dalle decisioni delle autorità, che determinano per lui il suo posto nella società, dove lavorerà e come vivere. Quando lo Stato assume tali funzioni, l’unica vera forma di potere rimane il potere dei funzionari o dei burocrati, cioè di coloro che controllano l’apparato coercitivo.
"Libertà e sicurezza"
In questo capitolo di The Road to Serfdom, Hayek si sofferma sul problema della disciplina che inevitabilmente sorge quando lo stato è impegnato nella pianificazione per un’intera nazione.
L'autore definisce l'esercito un'istituzione sociale che illustra una società pianificata. I dipendenti e le loro responsabilità sono determinati dal comando e, se c'è carenza di risorse, tutti finiscono con una dieta da fame. La sicurezza economica in questo sistema è garantita esclusivamente ai militari, ma è associata alla perdita della libertà personale.
"Perché i peggiori arrivano al potere?"

La parte del libro "The Road to Serfdom", di cui è riportato un riassunto in questo articolo, intitolata questa domanda retorica, ha suscitato il massimo interesse tra i lettori.
In questo capitolo cerca di affrontare l’affermazione secondo cui il totalitarismo non è un male in sé, ma è rovinato dalle figure storiche che si trovano al comando. Nelle sue testimonianze e riflessioni, l'autore convince il lettore che questa forma di potere è incompatibile con i valori individuali insiti nelle civiltà occidentali.
Se lo Stato o la società sono posti al di sopra dell’individuo, solo coloro i cui interessi coincidono con quelli collettivi ne restano i veri membri. Un prerequisito affinché un dittatore rimanga al potere è cercare un nemico (interno o esterno) e combatterlo senza pietà.
Dove esiste un obiettivo più alto, dove si ritiene che tutti i mezzi siano buoni per raggiungerlo, non esistono più regole e norme etiche. La crudeltà per motivi di dovere è giustificata; i collettivisti considerano i valori e i diritti dell'individuo un ostacolo al raggiungimento del risultato finale. Essendo devoti al loro ideale, sono pronti a commettere anche atti immorali e vili. Quando i valori stessi vengono stabiliti dal leader, i suoi subordinati vengono liberati dalle convinzioni morali. L’unica cosa richiesta loro è obbedire senza fare domande.
Non hanno più paura del lavoro sporco; portare a termine tali compiti diventa un biglietto per la vetta della carriera, verso il potere reale. Le persone che conservano ideali interiori si rifiutano di metterlo in pratica; solo le persone più senza principi lo faranno.
Hayek si riferisce a organizzazioni come SD e SS, al Ministero della Propaganda e alla Gestapo nel Terzo Reich, nonché a servizi simili in Italia, dove ai dipendenti viene richiesta principalmente la crudeltà, la capacità di intimidire, monitorare e ingannare.
"La fine della verità"
Nel capitolo “La fine della verità”, Hayek scrive che la coercizione non è sufficiente per raggiungere un unico obiettivo. È necessario che le persone credano nell'importanza e nella necessità di questo obiettivo. Ciò può essere ottenuto solo attraverso la propaganda. È necessario sostituire i concetti, perché bisogna convincere non solo dell'importanza dell'obiettivo in sé, ma anche dei metodi per raggiungerlo.
Il significato delle parole nel contesto della propaganda statale può cambiare a seconda delle circostanze esterne o interne. Critiche e dubbi vengono soppressi. Si sta introducendo un controllo totale sull'informazione, che colpisce anche aree completamente apolitiche.
Le radici del nazismo

Hayek introduce il concetto delle radici socialiste del nazismo, dimostrando quanto queste dottrine siano vicine tra loro.
Ad esempio, cita la frase e le opere di molti leader nazionalsocialisti che iniziarono la loro carriera politica come marxisti.
Obiettivi ideali

Hayek sostiene che nella società moderna le persone spesso rifiutano di obbedire alle leggi del mercato. È perfino pronto a sacrificare le sue libertà pur di ottenere un’effettiva sicurezza economica.
Tutto ciò porta a misure miopi che portano solo danni e portano al totalitarismo.
"Come sarà il mondo dopo la guerra?"
Questo è il titolo dell'ultimo capitolo di questo libro. Alla vigilia della prossima fine della guerra mondiale, l'autore rileva l'inammissibilità della formazione di organismi di pianificazione sovranazionali.
Secondo il filosofo, il governo internazionale può diventare il prototipo di una vera e propria dittatura, incarnando su larga scala le idee del nazionalsocialismo. Questa forma porterà alla tensione mondiale. La cosa principale è impedire che le nazioni sviluppate inizino a imporre con la forza le loro idee morali sugli altri. In questo caso rischiano di trovarsi nella posizione di dover decidere loro stessi sugli atti immorali, conclude l'autore.
Strada verso la schiavitù
Socialisti di tutti i partiti
Prefazione
La libertà, qualunque essa sia, di solito viene persa gradualmente.
David Hume
Quando uno scienziato sociale scrive un libro politico, è suo dovere dirlo direttamente. Questo è un libro politico e non voglio fingere che parli di qualcos'altro, anche se potrei designare il suo genere con un termine più raffinato, ad esempio un saggio socio-filosofico. Tuttavia, qualunque sia il titolo del libro, tutto ciò che vi scrivo deriva dal mio impegno verso alcuni valori fondamentali. E mi sembra di aver adempiuto ad un altro mio altrettanto importante dovere, avendo chiarito pienamente nel libro stesso quali sono i valori su cui si basano tutti i giudizi in esso espressi.
Resta da aggiungere che, nonostante si tratti di un libro politico, sono assolutamente sicuro che le convinzioni in esso espresse non siano espressione dei miei interessi personali. Non vedo perché una società del tipo che ovviamente preferisco mi concederebbe dei privilegi rispetto alla maggioranza dei miei concittadini. In effetti, come sostengono i miei colleghi socialisti, io, come economista, occuperei un posto molto più importante nella società a cui mi oppongo (se, ovviamente, potessi accettare le loro opinioni). Sono altrettanto fiducioso che il mio disaccordo con queste opinioni non sia una conseguenza della mia educazione, poiché sono state proprio queste a cui ho aderito in giovane età e sono state loro che mi hanno costretto a dedicarmi agli studi professionali in economia. Per coloro che, come ormai è consuetudine, sono pronti a vedere motivazioni egoistiche in qualsiasi presentazione di una posizione politica, lasciatemi aggiungere che ho tutte le ragioni per non scrivere o pubblicare questo libro. Senza dubbio offenderà molti con i quali vorrei rimanere in rapporti amichevoli. A causa sua ho dovuto rimandare altri lavori, che generalmente considero più importanti e per i quali mi sento più preparato. Infine, danneggerà la percezione dei risultati della mia attività di ricerca, in senso proprio, verso la quale sento una reale inclinazione.
Se nonostante ciò ho ritenuto mio dovere pubblicare questo libro, è stato solo a causa delle conseguenze strane e imprevedibili della situazione (appena percepibile dal grande pubblico) che si è sviluppata ora nelle discussioni sulla futura politica economica. Il fatto è che la maggior parte degli economisti sono stati recentemente coinvolti negli sviluppi militari e sono diventati muti a causa della posizione ufficiale che occupano. Di conseguenza, oggi l’opinione pubblica su questi temi è formata principalmente da dilettanti, da coloro che amano pescare in acque agitate o vendere a buon mercato un rimedio universale per tutte le malattie. In queste circostanze, chi ha ancora tempo per il lavoro letterario difficilmente ha il diritto di tenere per sé le paure che, osservando le tendenze moderne, molti condividono, ma non possono esprimere. In altre circostanze, lascerei volentieri il dibattito sulla politica nazionale a persone più autorevoli e più informate in materia.
Le principali disposizioni di questo libro furono riassunte per la prima volta nell’articolo “Libertà e sistema economico”, pubblicato nell’aprile 1938 sulla rivista Contemporary Review, e ristampato nel 1939 in una versione ampliata in uno dei “Socio-Political Pamphlets”, che pubblicato sotto la direzione del prof. GD Gideons University of Chicago Press. Ringrazio gli editori di entrambe queste pubblicazioni per avermi permesso di ristamparne alcuni estratti.
FA Hayek
introduzione
Volta è particolarmente irritato da quegli studi che rivelano il pedigree delle idee.
Signore Ekton
Gli eventi moderni differiscono da quelli storici in quanto non sappiamo dove conducono. Guardando indietro, possiamo comprendere gli eventi passati rintracciandone e valutandone le conseguenze. Ma per noi la storia attuale non è storia. È diretto verso l'ignoto e non possiamo quasi mai dire cosa ci aspetta. Tutto sarebbe diverso se avessimo la possibilità di rivivere gli stessi eventi una seconda volta, sapendo in anticipo quale sarebbe il loro risultato. Allora guarderemmo le cose con occhi completamente diversi e in ciò che ora notiamo a malapena vedremmo un presagio di cambiamenti futuri. Forse è meglio che tale esperienza sia chiusa all'uomo, che non conosca le leggi che governano la storia.
Eppure, sebbene la storia non si ripeta letteralmente e, d’altro canto, nessuno sviluppo degli eventi sia inevitabile, possiamo imparare dal passato per evitare la ripetizione di alcuni processi. Non è necessario essere un profeta per riconoscere il pericolo imminente. A volte una combinazione di esperienza e interesse consente improvvisamente a una persona di vedere le cose da un angolo che gli altri non vedono ancora.
Le pagine seguenti sono il frutto della mia esperienza personale. Il fatto è che sono riuscito a rivivere lo stesso periodo due volte, almeno due volte ad osservare un'evoluzione di idee molto simile. È improbabile che un'esperienza del genere sia disponibile per una persona che vive sempre in un paese, ma se vivi a lungo in paesi diversi, in determinate circostanze risulta realizzabile. Il fatto è che il pensiero della maggior parte delle nazioni civilizzate è soggetto sostanzialmente alle stesse influenze, ma queste si manifestano in tempi e velocità diverse. Pertanto, quando ci si sposta da un paese all'altro, a volte è possibile assistere due volte allo stesso stadio di sviluppo intellettuale. Allo stesso tempo, i sentimenti si aggravano stranamente. Quando si sentono per la seconda volta opinioni o appelli che si erano già sentiti venti o venticinque anni fa, acquistano un secondo significato, vengono percepiti come sintomi di una certa tendenza, come segni che indicano, se non l'inevitabilità, almeno , la possibilità dello stesso. come la prima volta, lo sviluppo degli eventi.
Forse è giunto il momento di dire la verità, per quanto amara possa sembrare; Il paese di cui rischiamo di ripetere la sorte è la Germania. È vero che il pericolo non è ancora alle porte e la situazione in Inghilterra e negli Stati Uniti è ancora molto lontana da quella osservata negli ultimi anni in Germania. Ma, anche se la strada da fare è ancora lunga, dobbiamo essere consapevoli che ad ogni passo sarà sempre più difficile tornare indietro. E se, nel complesso, siamo padroni del nostro destino, allora in una situazione specifica agiamo come ostaggi delle idee che noi stessi abbiamo creato. Solo riconoscendo in tempo il pericolo possiamo sperare di affrontarlo.
L'Inghilterra moderna e gli Stati Uniti non sono come la Germania di Hitler come l'abbiamo conosciuta durante questa guerra. Ma chi comincia a studiare la storia del pensiero sociale difficilmente ignora la somiglianza, tutt’altro che superficiale, tra lo sviluppo delle idee avvenuto in Germania durante e dopo la prima guerra mondiale e le tendenze attuali che si sono diffuse nei paesi democratici. Qui oggi sta maturando la stessa determinazione a preservare le strutture organizzative create nel Paese per scopi di difesa per utilizzarle successivamente per la creazione pacifica. Qui si sviluppa lo stesso disprezzo per il liberalismo ottocentesco, lo stesso “realismo” ipocrita, la stessa fatalistica disponibilità ad accettare “tendenze inevitabili”. E almeno nove lezioni su dieci che i nostri rumorosi riformatori ci spingono a imparare da questa guerra sono esattamente le stesse lezioni che i tedeschi hanno imparato dall’ultima guerra e da cui è stato creato il sistema nazista. Più di una volta in questo libro avremo l'opportunità di assicurarci che sotto molti altri aspetti stiamo seguendo le orme della Germania, restando indietro di quindici-venticinque anni. Alla gente non piace ricordarlo, ma non sono passati molti anni da quando i progressisti guardavano alle politiche socialiste della Germania come un esempio da seguire, proprio come negli ultimi tempi tutti gli occhi dei progressisti erano puntati sulla Svezia. E se scaviamo più a fondo nel passato, non possiamo fare a meno di ricordare quanto profondamente la politica e l’ideologia tedesca abbiano influenzato gli ideali di un’intera generazione di britannici e in parte americani alla vigilia della prima guerra mondiale.
L'autore ha trascorso più della metà della sua vita adulta nella sua terra natale, l'Austria, a stretto contatto con l'ambiente intellettuale tedesco, e la seconda metà negli Stati Uniti e in Inghilterra. Durante questo secondo periodo crebbe gradualmente in lui la convinzione che le forze che distrussero la libertà in Germania fossero all'opera, almeno in parte, anche qui, e che la natura e le fonti del pericolo fossero qui meno comprese che ai tempi della Germania. Qui non hanno ancora visto in pieno la tragedia accaduta in Germania, dove persone di buona volontà, considerate un modello e suscitate ammirazione nei paesi democratici, hanno aperto la strada a forze che ormai incarnano tutto ciò che più odiamo. Le nostre possibilità di evitare un simile destino dipendono dalla nostra sobrietà, dalla nostra disponibilità a mettere in discussione le speranze e le aspirazioni che coltiviamo oggi e a rifiutarle se contengono pericolo. Nel frattempo tutto suggerisce che ci manca il coraggio intellettuale necessario per ammettere i nostri errori. Non vogliamo ancora vedere che l’ascesa del fascismo e del nazismo non sia stata una reazione alle tendenze socialiste del periodo precedente, ma un’inevitabile continuazione e sviluppo di queste tendenze. Molti non vogliono riconoscere questo fatto anche dopo che le somiglianze tra le peggiori manifestazioni dei regimi nella Russia comunista e nella Germania fascista sono diventate più chiare. Di conseguenza, molti, rifiutando il nazismo come ideologia e sinceramente non accettando nessuna delle sue manifestazioni, sono guidati nelle loro attività da ideali, la cui attuazione apre un percorso diretto alla tirannia che odiano.